 Qualche giorno fa, per la prima volta, è stata battuta all’asta un’opera d’arte realizzata da un algoritmo. Si tratta di un dipinto, il ritratto di un presunto gentiluomo, non privo di una nota d’astrattismo, generato da una “macchina” cui è stato dato in pasto – come vuole il gergo ormai imperante – un data set di 15.000 ritratti dipinti tra il 14° e il 20° secolo. L’algoritmo, così come descritto dal collettivo cui si deve la paternità dell’opera (per interposta intelligenza artificiale), consta di due parti: l’una genera una nuova immagine sulla base del data set, l’altra cerca di scovare le differenze tra l’immagine così realizzata e un’immagine di fattura umana. Il risultato viene conseguito quando il ritratto generato dall’IA inganna la parte di algoritmo deputata a riconoscerne la vera genesi, passando per un’immagine reale*.
Qualche giorno fa, per la prima volta, è stata battuta all’asta un’opera d’arte realizzata da un algoritmo. Si tratta di un dipinto, il ritratto di un presunto gentiluomo, non privo di una nota d’astrattismo, generato da una “macchina” cui è stato dato in pasto – come vuole il gergo ormai imperante – un data set di 15.000 ritratti dipinti tra il 14° e il 20° secolo. L’algoritmo, così come descritto dal collettivo cui si deve la paternità dell’opera (per interposta intelligenza artificiale), consta di due parti: l’una genera una nuova immagine sulla base del data set, l’altra cerca di scovare le differenze tra l’immagine così realizzata e un’immagine di fattura umana. Il risultato viene conseguito quando il ritratto generato dall’IA inganna la parte di algoritmo deputata a riconoscerne la vera genesi, passando per un’immagine reale*.
La notizia è rimbalzata sui giornali più per la rilevanza della cifra a cui è stato battuto il quadro, oltre 430.000 dollari, che per le conseguenze di cui è gravida. A ben guardare l’irruzione dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte ci pone una serie di interrogativi, che muovono dall’annosa questione del significato dell’arte, come risulta subito evidente, ma che non vi rimangono circoscritti. Nel momento in cui gli autori esplicitano l’intenzione di mostrare che gli algoritmi sono capaci di emulare la creatività – una prerogativa in apparenza tipicamente umana – si insinua un’idea cara agli scrittori di science-fiction: il rischio che il confine ideale che separa l’uomo dalla macchina venga irrimediabilmente eroso. Se ci siamo abituati all’idea che molte attività, più o meno complesse ma pur sempre routinarie, si attaglino persino meglio alle capacità delle macchine, tendiamo a rifuggire dal pensiero che le espressioni di estro, creatività e spirito critico possano darsi al di fuori di un dominio tipicamente umano. A questo punto dovrebbe sorgere un’obiezione capace di sventare la minaccia paventata ai danni del nostro statuto ontologico. L’atto creativo, si potrebbe sostenere, non si manifesta nel processo dominato dall’algoritmo, ma nell’input fornito dall’uomo. In altre parole, si potrebbe ricondurre il ruolo della macchina a quello di un medium, facendone retrocedere il contributo, per quanto sofisticato, al rango (rassicurante) che le compete. Così Ahmed Elgammal, direttore dell’Art and Artificial Intelligence Lab alla Rutgers University:
You could say that at this point it is a collaboration between two artists — one human, one a machine. And that leads me to think about the future in which AI will become a new medium for art.’
Lo stesso Elgammal è abbastanza risoluto nel ritenere che vi sia un confine probabilmente invalicabile per la macchina:
[…] algorithm is capable of producing indisputable works of art? Perhaps it can — if you define a work of art as an image produced by an intelligence with an aesthetic intent. But if you define art more broadly as an attempt to say something about the wider world, to express one’s own sensibilities and anxieties and feelings, then AI art must fall short, because no machine mind can have that urge — and perhaps never will.
Le nostre ansie possono dunque essere placate? Questa urgenza di esprimersi attraverso l’arte discende da una consapevolezza (intesa in senso cartesiano) che per il momento attribuiamo solo all’uomo; l’urgenza di interrogarsi su di sé e sulla propria esistenza ci definisce e in questo ci rassicura sul nostro peculiare statuto ontologico. In verità, l’inquietudine di cui ci siamo sbarazzati poc’anzi, riportando la macchina al suo rango (subalterno), si fa nuovamente largo nel momento in cui, semplicemente, cambiamo visuale, smettiamo di interrogarci su quanto la macchina ci assomigli o possa assomigliarci e riflettiamo su quanto siamo noi ad assomigliarle. Un ulteriore stralcio dell’intervista a Elgammal chiarirà il punto. Commentando i risultati di altri sistemi di IA analoghi a quello che ha generato il ritratto – in particolare a quelli conseguiti da un sistema concepito per generare qualcosa di originale – Elgammal si interroga sull’evidente preponderanza di arte astratta. Sembra che l’algoritmo abbia afferrato la circostanza per la quale l’arte muove lungo una certa traiettoria e ne tragga le conseguenze, orientandosi verso l’astrattismo. Da qui la riflessione che ben coglie le ragioni di una rinnovata inquietudine:
This raises the intriguing notion that AI algorithms do not merely make pictures, they also tend to model the course of art history — as if art’s long progression from figuration to abstraction were part of a program that has been running in the collective unconscious for half a millennium, and the whole story of our visual culture were a mathematical inevitability.
L’esercizio di specchiarsi nell’intelligenza artificiale ci porta, in buona sostanza, a riflettere sulla matrice deterministica della nostra esistenza.
A questo punto ci si potrebbe forse lasciare con gli interrogativi che una simile riflessione reca inevitabilmente con sé. Eppure l’irruzione dell’IA nel mondo dell’arte, l’idea che essa possa ritagliarsi degli spazi nell’ambito di attività che ritenevamo appannaggio esclusivo dell’uomo, ci porta a riflettere su un altro tipo di minaccia intrinseca allo sviluppo di “macchine intelligenti”, una minaccia ben più prosaica: quella portata ai danni del lavoro.
L’impatto delle macchine sull’economia e sul mercato del lavoro è un fenomeno assai ampio e dibattuto; la loro introduzione ha giocato un ruolo fondamentale – nell’ambito di un insieme più ampio di variabili ricomprese sotto il cappello del progresso tecnologico – nel farci venir fuori da un’economia di tipo malthusiano, ma ha indotto ciclicamente delle trasformazioni tali da erodere, nel breve, occupazione e “occupabilità” della forza-lavoro. La vera domanda è se i più recenti sviluppi della tecnologia, segnatamente quelli legati all’IA, possano essere ricondotti nell’alveo di una dinamica già sperimentata, ciclica, oppure se quegli sviluppi rappresentino per qualche motivo una minaccia nuova e peculiare.
Sono un po’ le domande che si pongono Brynjolfsson e McAfee (2011) nel loro Race Against the Machine**. L’idea che le attuali tecnologie abbiano una maggiore portata distruttiva – rispetto al lavoro – si deve al fatto che le macchine si mostrano oggi capaci di una modalità di elaborazione dati – l’individuazione di modelli e regolarità – che sembrava peculiare dell’essere umano (si fa riferimento ai vari processi di machine learning, apprendimento automatico etc). Sul perché di questo improvviso balzo in avanti delle tecnologie Brynjolfsson e McAfee avanzano (o meglio sposano) l’idea per cui la progressione delle tecnologie legate a computer e ICT sia di tipo esponenziale e che ci saremmo mossi abbastanza sulla curva da apprezzarne finalmente la vera inclinazione.
Nell’illustrare le conseguenze di questa corsa contro le macchine, ormai in salita, gli autori evidenziano l’acuirsi di alcuni divari. Il ruolo sempre più centrale e pervasivo della tecnologia tenderebbe ad aprire la forbice tra lavoro qualificato e non, a tutto vantaggio del primo in termini di remunerazione, e tra lavoro e capitale, con quest’ultimo a ritagliarsi una fetta sempre più ampia della torta (a fronte di una diminuzione dell’importanza relativa del lavoro nel processo produttivo). Se si considera che la distribuzione del reddito non è neutrale rispetto alla stessa crescita economica (per tacere della sua redistribuzione) appare evidente come l’impatto della tecnologia sulla remunerazione dei fattori produttivi finisca per essere un problema economico, prima che politico.
Le inquietudini tratteggiate, le più aleatorie, affrontate in apertura e quelle più prosaiche, appena lambite, sottendono lo stesso interrogativo: riuscirà l’uomo a mantenere alcune delle sue prerogative? Possiamo forse aggrapparci all’idea vagheggiata sopra, che le macchine non saranno mai in grado di riflettere sulla propria condizione… ammesso che il post che state leggendo non sia opera di un algoritmo.
*Si tratta di una classe di algoritmi noti come Generative Adversarial Networks (GAN).
**Brynjolfsson, E., and McAfee, A. (2011). Race against the machine, Digital Frontier Press, Lexington, MA.

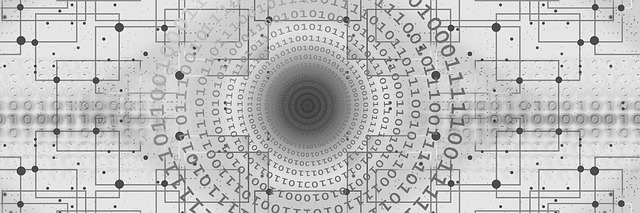










 Le parole sono importanti… urlava Nanni Moretti in una memorabile scena di Palombella Rossa. Ebbene, questo è tanto più vero per i discorsi di insediamento dei presidenti americani. L’ultimo in ordine di tempo, quello pronunciato ieri dal neoeletto Donald Trump si è sicuramente ritagliato un posto nella storia, non per l’eloquenza o la profondità di pensiero che (non) vi sono implicite, ma per la sua inusuale ruvidezza.
Le parole sono importanti… urlava Nanni Moretti in una memorabile scena di Palombella Rossa. Ebbene, questo è tanto più vero per i discorsi di insediamento dei presidenti americani. L’ultimo in ordine di tempo, quello pronunciato ieri dal neoeletto Donald Trump si è sicuramente ritagliato un posto nella storia, non per l’eloquenza o la profondità di pensiero che (non) vi sono implicite, ma per la sua inusuale ruvidezza.


 Detto questo, non è un caso che la gestione di MPS sia diventata più spregiudicata negli anni che preparavano la più grande crisi finanziaria di tutti i tempi. Vi sono almeno due elementi da tenere in considerazione. Il primo ha a che vedere col ciclo economico. In una fase di espansione, di crescita, gli attori che operano nei mercati sono portati ad assumere maggiori rischi, a cavalcare l’onda. Quando la parabola comincia il suo tratto discendente, le dinamiche si invertono e la situazione degenera tanto più rapidamente e pesantemente quanto più in alto si inscrive idealmente il vertice della parabola.
Detto questo, non è un caso che la gestione di MPS sia diventata più spregiudicata negli anni che preparavano la più grande crisi finanziaria di tutti i tempi. Vi sono almeno due elementi da tenere in considerazione. Il primo ha a che vedere col ciclo economico. In una fase di espansione, di crescita, gli attori che operano nei mercati sono portati ad assumere maggiori rischi, a cavalcare l’onda. Quando la parabola comincia il suo tratto discendente, le dinamiche si invertono e la situazione degenera tanto più rapidamente e pesantemente quanto più in alto si inscrive idealmente il vertice della parabola.